Palermo – La professoressa Ornella Giambalvo, docente ordinario di Statistica sociale all’Università di Palermo, una delle circa 3.600 donne (quasi il 19% del totale) che ricoprono quest’importante ruolo nelle università italiane, l’ho già intervistata nell’aprile 2014 (qui il link).
Mi avevano allora colpita e commossa il suo impegno concreto nel volontariato a Palermo, l’amicizia speciale con Lucio Dalla e il racconto di un viaggio in Tunisia nel 1998, con il ‘miracolo’ di una luna immensa che illuminava sette persone ‘perse’ nel deserto del Sahara, senza tablet e telefonini, in compagnia solo di un ragazzino del luogo e quattro dromedari.
Ornella è una viaggiatrice instancabile e appassionata: a casa sua c’è un pannello/planisfero con tante bandierine, una per ogni luogo del pianeta che ha visitato. Ma, a marzo scorso, andare in Tanzania, a Usolanga (circa 70 km da Iringa, città del centro-sud del Paese), uno dei ventidue villaggi appartenenti alla missione cattolica di Ismani, è stato un viaggio speciale… E non certo perché, oltre all’aereo per Addis Abeba e poi per Dar es Salaam, ci sono volute quindici ore di macchina in strade sterrate per arrivarci…
Professoressa Giambalvo, racconti da cosa è nato questo viaggio?
A questa domanda potrei rispondere almeno in 10 modi. Mi limito a 3: dal mio desiderio di conoscenza; dalla mia voglia di “costruire” il bene comune; da don Saverio Catanzaro. Sintetizzando queste tre risposte posso dirti che della missione di Ismani sento parlare da quando sono nata. Don Saverio Catanzaro, prete della diocesi di Agrigento e fondatore della missione, è amico della mia famiglia dal 1962, da prima della mia nascita. Don Saverio, oggi novantenne ma ancora tenace e dinamico, con l’energia di un giovanotto, è partito in missione a Ismani nel novembre del 1972. E quando tornava per un periodo limitato dalla ‘sua missione’, ci raccontava quello che stava facendo (costruiva scuole, chiese, pozzi, casette, strade...), del servizio e della disponibilità offerta alle persone povere. Io lo ascoltavo sempre in religioso silenzio e immaginavo… i miei coetanei di Ismani, la scuola di Ismani… la vita, là.
Avevo forse dieci anni quando, a un tizio che lo aveva apostrofato così: “Don Saverio, come si sta laggiù con gli zulù?!” lo sentii rispondere con una battuta secca e definitiva: “Mi sa che i veri zulù siete voi…” che dà l’idea del suo spirito battagliero.
A gennaio, alla sua ennesima proposta ad accompagnarlo in Tanzania, ho detto sì.
Un sì convintissimo, tanto da lasciare stupito anche lui.
Qual è stata la situazione più difficile da affrontare?
In generale, lasciare i bambini per strada che ci facevano festa, vedere malati in paziente e fiduciosa attesa di cure, incrociare occhi desiderosi di attenzione e pieni di povertà. Fra tutte, la delusione dei bimbi quando andavamo via, era dura da digerire.
E poi mi ha colpito vedere un bambino arrivato con una maglietta bucata, tutta toppe, che non andava bene neppure come strofinaccio, indossare con occhi luccicanti la maglietta azzurra che gli era stata donata. Per riprendere poi da terra la sua vecchia maglietta lercia e strappata… Che gli rividi addosso qualche giorno dopo. Evidentemente la maglietta azzurra era un dono troppo prezioso, da custodire bene, centellinandone l’utilizzo.
E il momento più bello? (continua su il Punto Quotidiano)
Maria D'Asaro, il Punto Quotidiano, 17 agosto 2025



































.jpg)

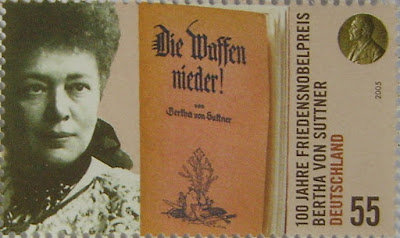

.jpg)

